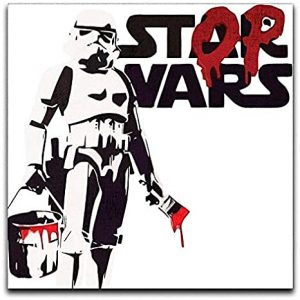Autore: Don Fabrizio
Un cuore aperto al mondo intero
Proseguiamo il nostro itinerario riflessivo sulla fraternità. Proviamo a concentrarci sulla sua connessione con la dinamica della missione. Una comunità credente, un gruppo parrocchiale sono destinati ad alimentare la fede e, nel contempo, ad aprirsi per confessare la fede, per condividerla nella gratuità e nella coerenza di vita. Non solo, “uscendo” per portare l’annuncio, sono tenuti ad avere l’intelligenza e l’umiltà di imparare dagli altri, da tutti gli altri, nominalmente anche dai non credenti, poiché lo Spirito del Risorto agisce con libertà nel distribuire i suoi doni. Ricordo come da giovane prete mi fu chiesto di cimentarmi in una piccola fraternità presbiterale, che aveva il compito di abbozzare operativamente una forma di condivisione abitativa e di cooperazione pastorale. Il sogno fallì ancor prima di essere implementato. Non ci fu la cattiveria di qualcuno in particolare. La fragilità dell’operazione stava nel suo essere – all’epoca –orchestrata in termini direttivi e verticistici, pur animati dalle migliori intenzioni. Poveri superiori! Ciò che mi colpì fu l’entusiasmo
delle comunità parrocchiali alle quali questa piccola cellula fraterna doveva essere d’aiuto. Erano commosse, comprendevano che già il fatto di procedere “aggregati” e non “in solitaria” profumava di Vangelo, possedeva una marcia misteriosa in più, si avvicinava all’ideale
LA PRASSI FRATERNA DELL’ANNUNCIO DEL VANGELO
Scusandomi per l’incipit autobiografico, sarebbe cosa buona essere il più possibile oggettivi e meno ripiegati sui propri personalissimi vissuti, mi riprendo immediatamente evocando la prassi fraterna di annuncio dell’evangelo riscontrabile nelle pagine del Nuovo Testamento. Bastano degli accenni. «Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi» (Lc 10,1). Si apprezzi come l’intero gruppo dei settantadue viene ingaggiato dallo stesso Gesù in una sorta di missione sperimentale. Un gruppo estroflesso – dunque –, non intruppato e autoreferenziale all’interno di una bolla o comfort zone attorno al Cristo. Estroflesso e missionario anche nella sua forma, essendo gli interessati inviati non singolarmente, ma in coppia, a “due a due”, sinodali, cooperativi. Non vi è nessun
intento settario e aggressivo: «Andate: vi mando come agnelli in mezzo a lupi» (Lc 10,3). L’operazione è animata dalla sola, gioiosa e gratuita volontà di annunciare la paternità tenera del Padre: «Dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”» (Lc 10,9). I riferimenti si sprecano. Mi piace qui evocare una celebre coppia che, in Atti degli Apostoli, si muove almeno inizialmente con forte complicità e libertà: Barnaba e Paolo: «Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e istruirono molta gente» (At 11,25-26). La missione fraterna domanda condivisione di obiettivi, dialogo nella fede, superamento di rivalità, risultando in tal modo di impatto maggiore poiché tra i due emerge – al meglio – un Terzo, o un Altro, per il quale vengono spese volentieri le energie. Allargando lo sguardo, il capitolo quarto dell’enciclica Fratelli Tutti – magistero datato 2020 – riporta un titolo che sulle prime potrebbe essere inteso in termini riduttivi, esclusivamente ecclesiali: «Un cuore aperto al mondo intero». In realtà ci si indirizza alle comunità umane nazionali, anch’esse forme di fraternità, sollecitandole a essere porose, interconnesse in modo intraprendente e intelligente. Sono invitate ad aprirsi all’inclusività e all’integrazione di fronte alla sfida dell’emigrazione; a superare preconcetti e barriere culturali, uscendo da ottiche localistiche, nazionalistiche, sovraniste e difensive; a far circolare in uno scenario di fraternità universale il patrimonio umanistico e tecnico dell’Occidente e il patrimonio contemplativo e immaginifico dell’Oriente; a immaginare un nuovo ordine mondiale non disegnato dall’equilibrio politico e militare delle forze in campo – sempre precario e a svantaggio dei più deboli –, ma dal bene della pace, dalla costruzione di un’umanità che, come suggerisce Francesco, si ispiri al poliedro, figura geometrica ospitale, dove la varietà si celebra nella coesione e nella festa.
I CANTIERI DELLA LIBERTÀ E FANTASIA
Riabbassandomi di quota, per tornare a scenari più consueti e pastorali, accenno a due cantieri nei quali possiamo come Chiesa e come Ac sperimentarci con libertà e fantasia. Mi chiedo, perché le tanto decantate Unità pastorali, aborrite da una buona fetta di pastoralisti e di ecclesiologi, e guardate con sospetto e insofferenza da un discreto numero di laici e di pastori, nonostante l’insistenza organizzativa e giuridica dei vescovi, non possano essere concepite come grembi fraterni e generativi, cantieri di missionarietà? Perché debbono essere derubricate a operazioni di ingegneria pastorale che mortifica le bellezze delle differenti identità locali, riducendole alla sterilità? Chi l’ha detto che una scelta dettata dal motivo tecnico della decurtazione del numero dei presbiteri non possa essere trasformata in una alleanza dove nulla si cancella, ma tutt’al più ci si libera da zavorra inutile? Coalizzandosi, procedendo collegialmente e sinodalmente, integrando le forze, sperimentando… possiamo negare che i frutti non arrivino? Ne siamo proprio sicuri? Finisco con un ultimo squarcio su una modalità missionaria a tutto tondo, che va dal pastorale, al culturale, al sociale, all’ambientale, all’economico al politico. L’Azione cattolica sta sposando, con sempre maggior generosità e sicurezza, la politica delle alleanze, relazionandosi e co-progettando con i mille soggetti che popolano i territori. Ovviamente rimane fedele alla sua indole ecclesiale e formativa. Lungi da noi volontà manipolatorie e strumentali. Ci anima l’esclusivo desiderio di lavorare per il bene e di essere latori di un annuncio generativo di storia di salvezza. Dal Bilancio di sostenibilità del 2022, on line e scaricabile dal sito dell’Ac, segnaliamo una delle modalità più vivaci di interazione: «La campagna “Chiudiamo la forbice: dalle diseguaglianze al bene comune, una sola famiglia umana” pone questo tema all’attenzione di tutti, declinandolo in tre ambiti: produzione e consumo del cibo, pace e conflitti, mobilità umana nel quadro delle nuove sfide sociali e climatiche». Sempre con spirito di verità, senza pretendere nessun applauso, confermiamo tale indirizzo ricordando un progetto in atto partito il 3 marzo, facente parte di una alleanza più larga. Eccolo: «#abbraccioperlapace, Campagna di mobilitazione per promuovere l’apertura di tavoli di dialogo tra le comunità ucraine e russe presenti in Italia, arginando e prevenendo l’odio che potrebbe divampare tra i due popoli fratelli in conseguenza dell’aggressione Russa all’Ucraina». Impossibile allora per una autentica fraternità che essa si ripieghi su sé stessa, ingobbita, perdendo tempo a osservarsi l’ombelico. Alla fraternità appartiene una verità e un fascino che la spingono inesorabilmente e potentemente a diffondersi, a svilupparsi, a cercare modalità infinite per esprimersi. Essa possiede un cuore universale.
Don Fabrizio De Toni
Assistente centrale Settore adulti AC e Mlac
Dalla rivista dell’AC “Segno nel mondo” n.3 2022
Forbice pasquale
La metafora della forbice la trovo “tagliente” ed efficace. Già negli anni ’80, tra i banchi dello studio teologico che frequentavo, studiando e commentando la dottrina sociale elaborata da Papa Wojtyla, la forbice ritornava come un refrain per evocare ingiustizia sociale, separazione, distanza (allora) tra Nord e Sud della terra, tensioni, discordia. Una forbice, maneggiata dall’arroganza e dall’istinto di predazione, che lacerava e lacera il tessuto umano facendolo sanguinare. Nel contempo una forbice da “chiudere”, come recita intelligentemente e responsabilmente lo slogan dell’alleanza “Chiudiamo la forbice”. Il patto nasce per segnalare le separazioni e le polarizzazioni esistenti, per studiarne i meccanismi e proporne delle prospettive di superamento.
Poco prima della crisi finanziaria ed etica del 2008 partecipai ad un viaggio missionario in Africa. La guida, un missionario di lungo corso, ci invitò a scrutare la distesa notturna della savana. Dal nostro punto di osservazione si presentava come una sorta di vasta conca che si separava dal monte Kenya. Ci colpirono alcune “inspiegabili” lame di luce poste in modo irregolare a fendere il buio sul terreno. Scoprimmo il giorno seguente essere delle serre di proprietà di grosse multinazionali – illuminate a giorno ed innaffiate da acqua potabile – per la coltivazione delle rose e dei fagiolini destinati ad arrivare sulle tavole europee. Accanto, villaggi di migliaia di lavoratori pagati 2 dollari al giorno, senza luce elettrica e privi di acqua. Un presagio, o – meglio – un segnale di una triste e lunga catena di storie non raccontate di sfruttamento e di iniquità. Esse arrivano dal passato, ed ora vengono riedite nella versione di esodi migratori, privazione del cibo necessario, concentrazione colossale di potere economico nelle mani di pochissimi super ricchi (vedi le analisi autorevoli di Oxfam), polarizzazioni culturali… guerra e guerre, una guerra – folle e feroce – di aggressione all’Ucraina.
Appoggiandoci all’intelligenza teologica del Vangelo di Giovanni, potremo dire che Dio ha tanto amato il mondo da immergervi il Figlio (cfr. Gv 3,16). Un battesimo nelle aspirazioni e nelle speranze, come pure nelle contraddizioni e lotte crudeli dell’umanità sino al punto di consentire alle misteriose forbici del male di “lacerarlo”. Uno squarcio generativo, infatti “dalle sue piaghe siamo stati guariti” (cfr. 1Pt 2,24). Perché non contemplare con ammirazione la solidarietà larga per i profughi, l’intercessione di tanti piccoli, i primi tentativi di immaginare un nuovo ordine mondiale fondato sui beni comuni e sul bene comune come le cicatrici di una guarigione, in parte accaduta? Sono tutte tracce, umili e povere eppure veraci, dell’azione del Figlio. Egli non si è fermato di fronte al muro dell’ostilità e del rifiuto, anzi ha reso la sua faccia dura come pietra (cfr. Is 50,7) per demolire ogni muro di inimicizia, per ricostruire una fraternità infranta e riconciliarci con il Padre (cfr. Ef 2,14.16). Il gemito della terra e il pianto degli umani non sfugge alle orecchie del cuore materno e paterno di Dio.
Il Signore Gesù, morto e risorto, è simile ad una pianta recisa e rifiorita. Una pianta misteriosa che affonda e allunga le sue radici per trasformare ogni scenario desolato e funereo in un’oasi di speranza. «Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini» (Ef 2,17). Buona Pasqua!
Don Fabrizio De Toni
Assistente centrale Settore adulti AC e Mlac
articolo pubblicato l’11 aprile 2022 sul sito
Transizione e conversione ecologica
Le due prospettive, la prima culturale e politica – la transizione ecologica – mentre la seconda tipica del magistero bergogliano – la conversione ecologica -, pu r partendo da presupposti differenti non sono divergenti, anzi! Entrambe si riconoscono, si rinforzano, si cercano e si stanno alleando nella riflessione e nella prassi. I movimenti ecologisti e green del secolo scorso, nati come reazione ai disastri ambientali dovuti al cambiamento climatico, all’inquinamento e alla voracità energetica, da aggregati di nicchia si sono trasformati in sensibilità culturale diffusa. L’attivista Greta Thumberg e i correlati Fridays for Future sono una espressione iconica ed efficace di una attenzione planetaria sempre più condivisa.
r partendo da presupposti differenti non sono divergenti, anzi! Entrambe si riconoscono, si rinforzano, si cercano e si stanno alleando nella riflessione e nella prassi. I movimenti ecologisti e green del secolo scorso, nati come reazione ai disastri ambientali dovuti al cambiamento climatico, all’inquinamento e alla voracità energetica, da aggregati di nicchia si sono trasformati in sensibilità culturale diffusa. L’attivista Greta Thumberg e i correlati Fridays for Future sono una espressione iconica ed efficace di una attenzione planetaria sempre più condivisa.
Non solo, la passione ecologica sta generando azioni creative e articolate di cittadinanza attiva – tra le quali possiamo annoverare il “Contest di progettazione sociale Mlac” -, insieme a progettualità politica strutturale (vedi l’agenda ONU 2030). Ovviamente con tutte le contraddizioni e i ritardi del caso che conosciamo. L’obiettivo è di invertire la rotta ecologica, attivando politiche, prassi, stili di vita che abbiano con la terra un impatto sostenibile e responsabile.
 L’oikos,casa comune e bene comune, se trattato con intelligenza etica ci consente di esperimentare la gioia della vita fraterna, e nel contempo di consegnarlo come eredità integra alle generazioni che
L’oikos,casa comune e bene comune, se trattato con intelligenza etica ci consente di esperimentare la gioia della vita fraterna, e nel contempo di consegnarlo come eredità integra alle generazioni che
attendono. Andando ai fondamentali teologici che riguardano il rapporto uomo e ambiente, incontriamo nel libro della Genesi gli imperativi soggiogate e dominate la terra (cfr. Gen 1,28). Essi possono dare l’impressione di un approccio di timbro predatorio e addirittura di considerarlo legittimo. Ad una lettura meno superficiale si scopre che l’uno è legato all’esplorazione di un territorio sconosciuto (soggiogate), mentre l’altro (dominate) all’attività affettuosa e solerte del pastore buono. Si coglie perciò una esortazione ad entrare nel giardino della creazione con stupore, gratitudine, intraprendenza e assennatezza. Poco oltre, nel medesimo libro biblico, ci imbattiamo nei verbi coltivare e custodire (cfr. Gen 2,15). Vanno presi come altre due coordinate che Dio consegna all’uomo, integrando ed ampliando le precedenti. Suggestivo risulta il sapere che l’azione del coltivare viene presa dall’ambito liturgico e quella del custodire dalla fedeltà all’alleanza che corre tra Dio e l’uomo. Agli occhi del credente il lavoro appare come una preghiera, un canto liturgico, una trasformazione e una offerta celebrativa, ed insieme la cura e la custodia si caricano di senso relazionale, vale a dire vengono interpretati come obbedienza ai comandi e ai piani di Dio: è Lui il primo ad aver cura e a custodire. Da queste poche note, che andrebbero allargate in uno studio serio e approfondito, si evince già come la conversione ecologica si fondi su una relazione di fede. Lo sguardo credente e contemplativo sulla creazione non ci distrae con visioni romantiche e fughe dalla storia, infatti ci spinge alla partecipazione e al servizio, fornendoci motivazioni, obiettivi e passione.
 Inoltre, il magistero che sostiene e argomenta la prospettiva della conversione ecologica si approccia all’ambiente in una visione – e quindi in una strategia – integrata e sistemica, arrivando a coniare la felice espressione di “ecologia integrale”. Tutto in fondo è connesso (cfr. Laudato si’) e in rapporto reticolare tra ambiente, culture, economia e politica. L’interpretazione globale nel pensiero teologico e sociale evita la frammentazione; riesce a cogliere nella crisi etica e nella tecnocrazia dominante, con una analisi lucida e profetica, la radice dei guasti planetari; in aggiunta favorisce una attenzione ai più svantaggiati, generati dalle emergenze ambientali e dalle conflittualità sociali. Non ci si scordi che i piccoli e i crocifissi sono i prediletti di Colui che ha immaginato e creato tutte le cose. Fenomeni come la pandemia o il più recente e pericolosissimo scontro bellico in Ucraina andrebbero affrontati con gli strumenti offerti dal magistero, intuendo alla fine che la terra e l’uomo domandano una conversione, un “contest” (gara) di immaginazione, una ideazione dando gambe a nuovi modelli di abitare, di cura, di incontro fraterno.
Inoltre, il magistero che sostiene e argomenta la prospettiva della conversione ecologica si approccia all’ambiente in una visione – e quindi in una strategia – integrata e sistemica, arrivando a coniare la felice espressione di “ecologia integrale”. Tutto in fondo è connesso (cfr. Laudato si’) e in rapporto reticolare tra ambiente, culture, economia e politica. L’interpretazione globale nel pensiero teologico e sociale evita la frammentazione; riesce a cogliere nella crisi etica e nella tecnocrazia dominante, con una analisi lucida e profetica, la radice dei guasti planetari; in aggiunta favorisce una attenzione ai più svantaggiati, generati dalle emergenze ambientali e dalle conflittualità sociali. Non ci si scordi che i piccoli e i crocifissi sono i prediletti di Colui che ha immaginato e creato tutte le cose. Fenomeni come la pandemia o il più recente e pericolosissimo scontro bellico in Ucraina andrebbero affrontati con gli strumenti offerti dal magistero, intuendo alla fine che la terra e l’uomo domandano una conversione, un “contest” (gara) di immaginazione, una ideazione dando gambe a nuovi modelli di abitare, di cura, di incontro fraterno.
Don Fabrizio De Toni
Assistente centrale Settore adulti AC e Mlac
articolo pubblicato su
Il coraggio di progettare
Il titolo suggeritomi “Il coraggio di progettare” contiene un sostantivo che la situazione pandemica, lentamente mutante in post pandemica, invoca. Essa infatti interpella gli animi, e nel contempo le istituzioni, compresa l’ecclesiale, ad un coraggio intraprendente. La relisienza è necessaria ed eroica, ad ogni buon conto da sola non è sufficiente. Alle insidie virali, con le sofferenze e i danni correlati, non basta opporre l’argine della tenacia. Esse domandano di essere superate e trasformate in lezioni dalle quali apprendere ad immaginare nuovi stili e cammini. Ed ecco allora affacciarsi il verbo progettare, da “pro jacere” ovvero “gettare avanti” lo sguardo, con speranza. Beninteso che la Bibbia non è opportuno scambiarla per un “Bignami” pronto per ogni occasione; tuttavia, può essere interrogata circa il progettare, con l’intento di ricavarne alcune linee guida sapienziali. Affondando la mano in tutta libertà per rapinare alcuni fili di perle dal grande baule della Sacra Scrittura, con umiltà, ci vengono sott’occhio alcuni passaggi. Ne scelgo due. Marco, nel primo capitolo del suo vangelo, costruisce volutamente una giornata ideale di Gesù. Emerge in forma schizzata uno “schema progettuale”. Il tempo non veniva impiegato a casaccio o consentendo ai bisogni di volta in volta incontrati di dettare i modi dell’impegno, in una continua improvvisazione e variazione. Egli pregava, predicava, guariva e godeva dell’amicizia. Le ore quindi erano ben scandite dall’attività pastorale, terapeutica, orante e relazionale, anche se non vi era rigidità. L’obiettivo che premeva nell’animo del Maestro stava nell’annuncio del Regno, e il dinamismo missionari andava in qualche modo ordinato per non essere dispersivo. Andando alle Beatitudini di Matteo, contenute al capitolo quinto, troviamo un testo che si presenta tecnicamente come Vangelo, lieto annuncio, voce profetica. Nello stesso tempo, tenendo per vero che una delle connotazioni trasversali dell’opera di Matteo è il “fare”, l’operatività, la concretezza, le Beatitudini si possono considerare un manifesto progettuale. Posto attenzione a non scambiarle per un programma formativo articolato e compiuto, o per un progetto sociale e politico, esse rivelano il disegno complessivo del Padre per i suoi figli. Un disegno da cui si traggono atteggiamenti, indicazioni, principi etici che possono già essere tradotti in valutazioni, scelte, pratiche. Più ancora, sono come un materiale grezzo che andrà elaborato, sviluppato in itinerari, iniziative, cultura… progettualità appunto. Gesù apre il cantiere della salvezza, pone la prima pietra, anzi è la pietra d’angolo (cfr. Mc 12,10), per una costruzione che richiede l’azione dello Spirito e la cooperazione permanente dell’uomo. Lo slancio missionario e operativo dell’evangelizzatore e del costruttore di pace e di fraternità sa inoltre che lo attendono ostacoli ed impedimenti, dai quali può ricevere – per grazia – un misterioso impulso sempre dallo Spirito, così da non scoraggiarsi. A questo punto va detto che il principio e fondamento che ispira e anima la progettualità è l’Incarnazione. Il Figlio si fa uomo, la Parola diventa storia. Dal semino del Vangelo cresce la pianta del Regno, un embrione di Chiesa, che adagio adagio nel lungo percorso storico – attraverso discontinuità, sfide e sperimentazioni – darà vita ad una sorta di grande albero, avvicinandosi al quale si può osservare una strutturazione ecclesiale, la composizione del canone biblico, il sedimentarsi degli studi teologici, la modulazione di forme nuove per l’annuncio, la ricchezza liturgica, la fantasia caritativa, la fecondità culturale… Insomma, una progettualità incalzante, dettata dall’azione dello Spirito. Noi evidentemente siamo coinvolti ad elaborare con metodo e organicamente l’ultimo tratto di strada che arriva dalla spinta dell’Incarnazione. Essa va assecondata con slancio, tenendo ferma la barra per non cozzare nella navigazione sugli scogli di “Scilla e Cariddi”, perciò per una pesca fruttuosa che si tenga lontana dalla tentazione dell’iperattivismo affannato e esagitato o per converso dall’accidia e dall’astrazione. Non ci resta che piegare le ginocchia e… rimboccarci le maniche. Al… lavoro!
Don Fabrizio De Toni
Assistente nazionale Settore adulti AC e Mlac