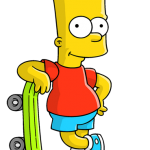Titolo curioso… o forse solo rompicapo inutile e che non merita investimento di energie… per me è una tesi interessantissima e verissima. Non intendo fare accademismi… senza averne i titoli, ma occuparmi della vita nella sua concretezza. Il titolo dice una cosa semplice pur nella sua complicazione espressiva: ciò che fa parte di noi e che non viene integrato (e quindi disgregato) nella nostra identità e nel nostro progetto vocazionale va per forza di cose per ‘gli affari suoi’ e, dal momento che comunque è un pezzo di noi, disturba, rovina, risulta come una sorta di palla al piede, addirittura può funzionare da elemento pericoloso, in ogni caso diviene disgregante. È una legge umana direi inevitabile. Ora mi piacerebbe operare un doppio sguardo: verso il passato e verso il futuro e cercare di dimostrare come tale tesi sia assolutamente attendibile.  E cioè: una memoria, un passato non integrato, con il quale non ci siamo riconciliati tende a disgregare, a far sentire il suo condizionamento, a toglierci libertà emotiva e intellettiva. Ancora, un presente e un futuro prossimo che contengono degli elementi che vengono percepiti come ostili, preoccupanti o quanto meno sgradevoli, che stentiamo a gestire in modo intelligente agiscono su di noi portando confusione, ansia, togliendoci libertà, destabilizzandoci, disgregandoci appunto. Fatta questa premessa, possiamo partire guardando il passato, la nostra storia personale o comunitaria. Pochi lo sanno, ma in tutti è presente e viva, esiste una memoria affettiva. L’essere umano registra le sue emozioni, soprattutto quelle a forte intensità e non le dimentica. Si perde la memoria dell’accadimento, dell’esperienza concreta, ma rimane in noi, come traccia indelebile, l’emozione generata da quella precisa esperienza. L’emozione archiviata poi esce, talvolta in modo dirompente, davanti a un qualsiasi motivo che anche solo per collegamento simbolico e vago richiama la prima esperienza. C’è in noi quasi una scatola nera contenente le emozioni primitive e che determina gusti, simpatie e antipatie, paure, desideri… Qualche autore sostiene che la memoria affettiva sia allora la madre del nostro presente e del nostro futuro. Non di rado capita che questa madre sia più matrigna che benigna. Facciamo un paio di esempi di segno opposto. Uno positivo. Un bambino nell’età della Scuola d’Infanzia o nei primi anni del Catechismo (pensiamo solo alla Messa di Prima Comunione) che sedimenta dentro di sé davanti alle immagini e alle esperienze del sacro un sentimento di stupore, di gratitudine, di fascinazione, avvertirà nella stagione dell’adolescenza o della maturità, con maggiore facilità, la percezione dell’incanto per ciò che è divino, nelle sue crisi sarà portato a ritenere che probabilmente di Dio ci si può fidare, nella sua ricerca di senso proverà attrazione per ciò che il Vangelo ritiene buono, vero e bello. L’emozione integrata, coerente con un progetto di vita aperto alla fede, si rivelerà integrante, consentirà di leggere e accogliere le benedizioni del Signore disseminate lungo il cammino, abiliterà a mettere in ordine la propria storia intorno ad una offerta educativa credente per la quale ci si può fidare, ad apprezzare la propria vera identità di creatura ad immagine somiglianza di Dio, da sempre amata da Lui e chiamata a fare come Lui. Un adulto che non abbia una memoria religiosa di questo tipo o non l’abbia affatto, sarà un adulto orfano, sicuramente più povero… senza memoria affettiva, senza ‘madre’, disintegrato e smarrito. Andiamo ora ad una memoria affettiva di segno negativo. Classico è il profilo che colui che ha intrattenuto con il padre una pessima relazione, portandosi dentro rabbia, rancore, fastidio, umiliazione, ribellione. Il figlio incompreso e mal-trattato davanti a tutto ciò che suona come autorità e imposizione sarà spinto ad agire in termini aggressivi, con la conclusione che talvolta penserà di essere un amante della giustizia, un uomo dall’alto senso della libertà, che non tollera forzature e arroganze, una specie di profeta che reagisce alla protervia altrui… senza avvedersi che sta lottando contro suo padre, il padre dell’infanzia, rispondendo alla tracotanza, o a ciò che lui giudica come tale, con altrettanta tracotanza, se non peggiore della prima: poveretto! Il tutto senza cattiveria (si capisce), perché gli sfugge la motivazione profonda, la radice del suo ‘santo’ disagio. Vedete come la memoria affettiva plasmi il presente, lo generi come una madre genera il figlio. Si comprende allora come sia utile e furbo imparare ad integrare la memoria affettiva, perché sia reale energia che aiuti e non disgreghi la nostra vera identità. Per guarire la memoria affettiva, sempre in parte ammalata perché le botte che prende in genere non vengono curate per tempo, si deve mettere le mani su di un materiale che non richiede, per essere individuato, l’accompagnamento di un esperto. Sto parlando della memoria storica: questa sì è chiara nella mente. È la memoria dei fatti non dimenticati, degli incontri, del percorso famigliare, amicale, lavorativo… ecclesiale. Una memoria affettiva poco sana, non guarita va a braccetto, quasi fosse la sorella preferita, con una memoria storica poco piacevole, ingrata, più o meno sofferente… disgregata e quindi disgregante. Gli scontenti, i brontoloni, i pessimisti, gli acidi sono, se guardati da vicino, perennemente in lotta con il loro passato remoto e recente. Vita infelice la loro, proprio perché il passato è sentito e ricordato come triste. Se non proprio infelice, almeno inquieta, velata di nervosismo e di pessimismo, poco gioiosa. Ciò che è stato viene visto come un campo di battaglia o come una sporta pesante da portare: malattie e prove, insuccessi, genitori non all’altezza, preti non all’altezza, amici insinceri, figli inconcludenti e torvi, e come se non bastasse, un Dio muto, impotente. Un passato degno solo di essere dimenticato, rimosso o di cui ricordare solo un parte… una storia non ben integrata e, come si può capire, disintegrante se non altro di una certa legittima e possibile serenità (che immancabilmente scappa). L’operazione di fondo da fare e rifare quotidianamente è la riconciliazione (l’integrazione) della memoria storica. Tutto il nostro percorso va accettato, guardato, preso così com’è. Ogni gesto e ogni silenzio, ogni gioia e ogni patimento, ogni volto e ogni immagine, ogni successo e ogni peccato. Accettare, va da sé, non significa approvare con olimpionica ingenuità, ma consentire che ciò che è stato sia. Accettare è permettere alla realtà storica di essere quella che è, senza eccessive vergogne e disperazioni. L’operazione suddetta da sola non è sufficiente. E’ basilare, ma fermarsi qui sarebbe roba per uomini psichici che non si aprono ad un reale cambiamento, ad una liberante conversione-integrazione. L’altro passo, assolutamente essenziale, è la gratitudine. Nessuno di noi è così sfortunato da non aver motivi per cui ringraziare. Chi con pazienza e con stupore impara a recuperare il cordoncino rosso delle benedizioni che gli uomini e Dio gli hanno accordato e che attraversa tutte le tappe della vita e che si fa ancor più robusto e riverberante dentro alle sue zone buie, s’accorgerà di essere creatura desiderata e amata, da sempre. Intuirà che non è uno sgorbio frutto del caso, ma un figlio che può avanzare con speranza, un dono che andrà condiviso con gli altri. La memoria affettiva ferita inizia così a guarire, le emozioni primitive di svilimento lasceranno spazio a sentimenti positivi, si muteranno in emozioni di fiducia. Eccola la memoria ’vera’, affettiva e storica insieme, grata e fiduciosa, la memoria-madre feconda di un presente e di un avvenire che si possono affrontare con entusiasmo, con generosità perché certi di essere stati ben voluti, perché sicuri di essere stati amati, sicuri di valere, convinti di essere capaci di amare, desiderosi di ricambiare. Interessanti questi ottimisti non stupidini, che non si sforzano di presentarsi con un sorriso ebete, ma che sorridono alla vita perché hanno appreso ad integrare la loro vita. Riguardo al futuro il meccanismo è il medesimo: tutto ciò che sta di fronte come possibilità e che non sappiamo digerire e gestire tende ad attaccare la nostra identità, a metterci sulla difensiva, a disgregarci. Mi sia consentito di focalizzare l’attenzione sul futuro pastorale. Nei prossimi 5 anni con ogni probabilità lo sforzo della pastorale diocesana mirerà a riconfigurare il tessuto pastorale in unità-zone pastorali, dove le singole identità parrocchiali non si dissolvono in un polverone caotico, ma divengono alleate e sorelle. Il progetto è indotto indubbiamente da un rapido invecchiamento del clero e dai nuovi ingressi in Seminario ridotti al lumicino, ma nello stesso tempo dalla volontà di far fronte alla tentazione di una vita presbiterale autoreferenziale (della serie la mia Canonica, la mia Parrocchia, il mio gruppo, le mie irrinunciabili e geniali idee…) e di una vita pastorale altrettanto autoreferenziale (il mio campanile, il mio prete, le mie suore, il mio Grest, ecc.). Dentro a questo panorama è evidente il limite: mancanza di preti, mancanza di suore, mancanza se non assenza di laici preparati, mancanza di ricette funzionanti… aumento di ‘pecore smarrite’ o che semplicemente preferiscono brucare altri foraggi e frequentare altre valli, svuotamento domenicale, inappetenza di fede… Se il limite non viene integrato e vissuto come una straordinaria opportunità, allora immediate sono le reazioni disgreganti o perlomeno insufficienti. E allora si passa da un approccio tecnico, di chi pensa di abbassare l’ansia esclusivamente moltiplicando piani-progetti-verifiche. Si dice che quando si sa dove andare, con competenza, allora ci si sente meno inadeguati e pian piano si recupera (o si finge di recuperare) gusto e convinzione. In questo sforzo quasi puramente di ingegneria pastorale dove sta l’anima del Pastore-Amante del suo gregge? Non ne viene fuori piuttosto un profilo da ‘operatore-meccanico pastorale’, da controllore della situazione che rischia di non controllare un bel nulla e di trovarsi più ansioso di prima? E si arriva ad un approccio aggressivo e disfattista di chi profetizza solo implosioni e collassi pastorali, di chi ritiene praticamente impossibile metter due preti sotto lo stesso tetto perché cresciuti con il mito del Parroco-Papa-e-Re e non tiene conto di non essere dispensato dal convertirsi dal suo individualismo, di chi si abbarbica penosamente e pateticamente al suo campanile (per salvarlo, si dice, senza accorgersi di isolarlo), di chi presume di non aver nulla da imparare dagli altri, di chi non ha mai letto il Vangelo della condivisione.Quando il limite non viene accettato con pacatezza, ma avvertito come minaccia, quando non viene metabolizzato ed integrato queste sono alcune delle logiche e poco entusiasmanti conclusioni. Lo stesso limite può essere valorizzato e gestito da credenti. Perché non interpretarlo come una provvidenziale Scuola Formativa, come un vuoto dove si nascondono le pro-vocazioni, gli appelli vocazionali di Dio? La povertà del futuro ci può educare all’umiltà, all’abbandonarci alla misericordia divina più che mai al lavoro quando si tratta di poveri, all’uscita dal nostro orticello, alla condivisione delle nostre risorse, all’apprezzamento della ricchezza altrui, alla responsabilità laicale (la Chiesa non è una bottega che si frequenta quando se ne decide la necessità, e che va aperta e tenuta in ordine senza prodotti scaduti e da preti aggiornati), al lavoro di squadra, al pensare insieme da cristiani e non da sciocchi rivali, all’andare incontro all’altro non perché mi è simpatico, ma perché me lo chiede il Vangelo. ‘Quando sono debole, è allora che sono forte’: così si confidava nella preghiera Paolo di Tarso che si era lasciato formare dalla prova e dalla necessità. Integrare allora per non disperdere, perché ogni frammento e soprattutto quello meno appariscente contiene energia, possiede a sua volta un frammento di grazia, la presenza dell’Eterno. Integrare perché, come Dio che non è venuto per condannare e brontolare, nulla vada perduto, tutto vada vissuto e goduto. Integrare per costruire, piantare, irrigare, vitalizzare, anche dove altri non vedono nulla di buono… e infine raccogliere, anzi questo è già raccogliere il frutto formato, il frutto della integrazione-formazione permanente! 24.07.2005
E cioè: una memoria, un passato non integrato, con il quale non ci siamo riconciliati tende a disgregare, a far sentire il suo condizionamento, a toglierci libertà emotiva e intellettiva. Ancora, un presente e un futuro prossimo che contengono degli elementi che vengono percepiti come ostili, preoccupanti o quanto meno sgradevoli, che stentiamo a gestire in modo intelligente agiscono su di noi portando confusione, ansia, togliendoci libertà, destabilizzandoci, disgregandoci appunto. Fatta questa premessa, possiamo partire guardando il passato, la nostra storia personale o comunitaria. Pochi lo sanno, ma in tutti è presente e viva, esiste una memoria affettiva. L’essere umano registra le sue emozioni, soprattutto quelle a forte intensità e non le dimentica. Si perde la memoria dell’accadimento, dell’esperienza concreta, ma rimane in noi, come traccia indelebile, l’emozione generata da quella precisa esperienza. L’emozione archiviata poi esce, talvolta in modo dirompente, davanti a un qualsiasi motivo che anche solo per collegamento simbolico e vago richiama la prima esperienza. C’è in noi quasi una scatola nera contenente le emozioni primitive e che determina gusti, simpatie e antipatie, paure, desideri… Qualche autore sostiene che la memoria affettiva sia allora la madre del nostro presente e del nostro futuro. Non di rado capita che questa madre sia più matrigna che benigna. Facciamo un paio di esempi di segno opposto. Uno positivo. Un bambino nell’età della Scuola d’Infanzia o nei primi anni del Catechismo (pensiamo solo alla Messa di Prima Comunione) che sedimenta dentro di sé davanti alle immagini e alle esperienze del sacro un sentimento di stupore, di gratitudine, di fascinazione, avvertirà nella stagione dell’adolescenza o della maturità, con maggiore facilità, la percezione dell’incanto per ciò che è divino, nelle sue crisi sarà portato a ritenere che probabilmente di Dio ci si può fidare, nella sua ricerca di senso proverà attrazione per ciò che il Vangelo ritiene buono, vero e bello. L’emozione integrata, coerente con un progetto di vita aperto alla fede, si rivelerà integrante, consentirà di leggere e accogliere le benedizioni del Signore disseminate lungo il cammino, abiliterà a mettere in ordine la propria storia intorno ad una offerta educativa credente per la quale ci si può fidare, ad apprezzare la propria vera identità di creatura ad immagine somiglianza di Dio, da sempre amata da Lui e chiamata a fare come Lui. Un adulto che non abbia una memoria religiosa di questo tipo o non l’abbia affatto, sarà un adulto orfano, sicuramente più povero… senza memoria affettiva, senza ‘madre’, disintegrato e smarrito. Andiamo ora ad una memoria affettiva di segno negativo. Classico è il profilo che colui che ha intrattenuto con il padre una pessima relazione, portandosi dentro rabbia, rancore, fastidio, umiliazione, ribellione. Il figlio incompreso e mal-trattato davanti a tutto ciò che suona come autorità e imposizione sarà spinto ad agire in termini aggressivi, con la conclusione che talvolta penserà di essere un amante della giustizia, un uomo dall’alto senso della libertà, che non tollera forzature e arroganze, una specie di profeta che reagisce alla protervia altrui… senza avvedersi che sta lottando contro suo padre, il padre dell’infanzia, rispondendo alla tracotanza, o a ciò che lui giudica come tale, con altrettanta tracotanza, se non peggiore della prima: poveretto! Il tutto senza cattiveria (si capisce), perché gli sfugge la motivazione profonda, la radice del suo ‘santo’ disagio. Vedete come la memoria affettiva plasmi il presente, lo generi come una madre genera il figlio. Si comprende allora come sia utile e furbo imparare ad integrare la memoria affettiva, perché sia reale energia che aiuti e non disgreghi la nostra vera identità. Per guarire la memoria affettiva, sempre in parte ammalata perché le botte che prende in genere non vengono curate per tempo, si deve mettere le mani su di un materiale che non richiede, per essere individuato, l’accompagnamento di un esperto. Sto parlando della memoria storica: questa sì è chiara nella mente. È la memoria dei fatti non dimenticati, degli incontri, del percorso famigliare, amicale, lavorativo… ecclesiale. Una memoria affettiva poco sana, non guarita va a braccetto, quasi fosse la sorella preferita, con una memoria storica poco piacevole, ingrata, più o meno sofferente… disgregata e quindi disgregante. Gli scontenti, i brontoloni, i pessimisti, gli acidi sono, se guardati da vicino, perennemente in lotta con il loro passato remoto e recente. Vita infelice la loro, proprio perché il passato è sentito e ricordato come triste. Se non proprio infelice, almeno inquieta, velata di nervosismo e di pessimismo, poco gioiosa. Ciò che è stato viene visto come un campo di battaglia o come una sporta pesante da portare: malattie e prove, insuccessi, genitori non all’altezza, preti non all’altezza, amici insinceri, figli inconcludenti e torvi, e come se non bastasse, un Dio muto, impotente. Un passato degno solo di essere dimenticato, rimosso o di cui ricordare solo un parte… una storia non ben integrata e, come si può capire, disintegrante se non altro di una certa legittima e possibile serenità (che immancabilmente scappa). L’operazione di fondo da fare e rifare quotidianamente è la riconciliazione (l’integrazione) della memoria storica. Tutto il nostro percorso va accettato, guardato, preso così com’è. Ogni gesto e ogni silenzio, ogni gioia e ogni patimento, ogni volto e ogni immagine, ogni successo e ogni peccato. Accettare, va da sé, non significa approvare con olimpionica ingenuità, ma consentire che ciò che è stato sia. Accettare è permettere alla realtà storica di essere quella che è, senza eccessive vergogne e disperazioni. L’operazione suddetta da sola non è sufficiente. E’ basilare, ma fermarsi qui sarebbe roba per uomini psichici che non si aprono ad un reale cambiamento, ad una liberante conversione-integrazione. L’altro passo, assolutamente essenziale, è la gratitudine. Nessuno di noi è così sfortunato da non aver motivi per cui ringraziare. Chi con pazienza e con stupore impara a recuperare il cordoncino rosso delle benedizioni che gli uomini e Dio gli hanno accordato e che attraversa tutte le tappe della vita e che si fa ancor più robusto e riverberante dentro alle sue zone buie, s’accorgerà di essere creatura desiderata e amata, da sempre. Intuirà che non è uno sgorbio frutto del caso, ma un figlio che può avanzare con speranza, un dono che andrà condiviso con gli altri. La memoria affettiva ferita inizia così a guarire, le emozioni primitive di svilimento lasceranno spazio a sentimenti positivi, si muteranno in emozioni di fiducia. Eccola la memoria ’vera’, affettiva e storica insieme, grata e fiduciosa, la memoria-madre feconda di un presente e di un avvenire che si possono affrontare con entusiasmo, con generosità perché certi di essere stati ben voluti, perché sicuri di essere stati amati, sicuri di valere, convinti di essere capaci di amare, desiderosi di ricambiare. Interessanti questi ottimisti non stupidini, che non si sforzano di presentarsi con un sorriso ebete, ma che sorridono alla vita perché hanno appreso ad integrare la loro vita. Riguardo al futuro il meccanismo è il medesimo: tutto ciò che sta di fronte come possibilità e che non sappiamo digerire e gestire tende ad attaccare la nostra identità, a metterci sulla difensiva, a disgregarci. Mi sia consentito di focalizzare l’attenzione sul futuro pastorale. Nei prossimi 5 anni con ogni probabilità lo sforzo della pastorale diocesana mirerà a riconfigurare il tessuto pastorale in unità-zone pastorali, dove le singole identità parrocchiali non si dissolvono in un polverone caotico, ma divengono alleate e sorelle. Il progetto è indotto indubbiamente da un rapido invecchiamento del clero e dai nuovi ingressi in Seminario ridotti al lumicino, ma nello stesso tempo dalla volontà di far fronte alla tentazione di una vita presbiterale autoreferenziale (della serie la mia Canonica, la mia Parrocchia, il mio gruppo, le mie irrinunciabili e geniali idee…) e di una vita pastorale altrettanto autoreferenziale (il mio campanile, il mio prete, le mie suore, il mio Grest, ecc.). Dentro a questo panorama è evidente il limite: mancanza di preti, mancanza di suore, mancanza se non assenza di laici preparati, mancanza di ricette funzionanti… aumento di ‘pecore smarrite’ o che semplicemente preferiscono brucare altri foraggi e frequentare altre valli, svuotamento domenicale, inappetenza di fede… Se il limite non viene integrato e vissuto come una straordinaria opportunità, allora immediate sono le reazioni disgreganti o perlomeno insufficienti. E allora si passa da un approccio tecnico, di chi pensa di abbassare l’ansia esclusivamente moltiplicando piani-progetti-verifiche. Si dice che quando si sa dove andare, con competenza, allora ci si sente meno inadeguati e pian piano si recupera (o si finge di recuperare) gusto e convinzione. In questo sforzo quasi puramente di ingegneria pastorale dove sta l’anima del Pastore-Amante del suo gregge? Non ne viene fuori piuttosto un profilo da ‘operatore-meccanico pastorale’, da controllore della situazione che rischia di non controllare un bel nulla e di trovarsi più ansioso di prima? E si arriva ad un approccio aggressivo e disfattista di chi profetizza solo implosioni e collassi pastorali, di chi ritiene praticamente impossibile metter due preti sotto lo stesso tetto perché cresciuti con il mito del Parroco-Papa-e-Re e non tiene conto di non essere dispensato dal convertirsi dal suo individualismo, di chi si abbarbica penosamente e pateticamente al suo campanile (per salvarlo, si dice, senza accorgersi di isolarlo), di chi presume di non aver nulla da imparare dagli altri, di chi non ha mai letto il Vangelo della condivisione.Quando il limite non viene accettato con pacatezza, ma avvertito come minaccia, quando non viene metabolizzato ed integrato queste sono alcune delle logiche e poco entusiasmanti conclusioni. Lo stesso limite può essere valorizzato e gestito da credenti. Perché non interpretarlo come una provvidenziale Scuola Formativa, come un vuoto dove si nascondono le pro-vocazioni, gli appelli vocazionali di Dio? La povertà del futuro ci può educare all’umiltà, all’abbandonarci alla misericordia divina più che mai al lavoro quando si tratta di poveri, all’uscita dal nostro orticello, alla condivisione delle nostre risorse, all’apprezzamento della ricchezza altrui, alla responsabilità laicale (la Chiesa non è una bottega che si frequenta quando se ne decide la necessità, e che va aperta e tenuta in ordine senza prodotti scaduti e da preti aggiornati), al lavoro di squadra, al pensare insieme da cristiani e non da sciocchi rivali, all’andare incontro all’altro non perché mi è simpatico, ma perché me lo chiede il Vangelo. ‘Quando sono debole, è allora che sono forte’: così si confidava nella preghiera Paolo di Tarso che si era lasciato formare dalla prova e dalla necessità. Integrare allora per non disperdere, perché ogni frammento e soprattutto quello meno appariscente contiene energia, possiede a sua volta un frammento di grazia, la presenza dell’Eterno. Integrare perché, come Dio che non è venuto per condannare e brontolare, nulla vada perduto, tutto vada vissuto e goduto. Integrare per costruire, piantare, irrigare, vitalizzare, anche dove altri non vedono nulla di buono… e infine raccogliere, anzi questo è già raccogliere il frutto formato, il frutto della integrazione-formazione permanente! 24.07.2005